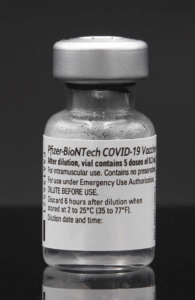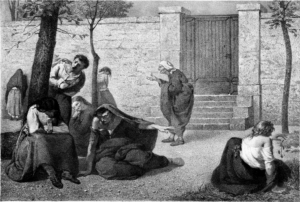Fonte foto: Wikipedia
Disturbo alimentare: quando il cibo diventa prigione e la cura un percorso di rinascita
Ogni 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, siamo chiamati a riflettere sul valore profondo del cibo: non solo come diritto universale, ma anche come espressione di cultura, salute e dignità. Tuttavia, proprio in questa giornata, è fondamentale ampliare lo sguardo e includere chi vive il cibo non come nutrimento, bensì come nemico, ossessione o prigione.
In effetti, il disturbo alimentare rappresenta una delle patologie psichiatriche più diffuse e, al tempo stesso, più sottovalutate in Italia. Nonostante la sua crescente incidenza, soprattutto tra i giovani, il fenomeno continua a svilupparsi in silenzio, alimentato da stigma, disinformazione e mancanza di risorse. Per questa ragione, è necessario parlarne con urgenza, affinché la consapevolezza diventi il primo passo verso la prevenzione e la cura.
Raccontarlo significa rompere il tabù, offrire strumenti di comprensione e costruire ponti di cura.
Che cos’è un disturbo alimentare?
Il disturbo alimentare è una condizione psichiatrica caratterizzata da comportamenti disfunzionali legati all’alimentazione, accompagnati da un’alterata percezione del corpo e da una profonda sofferenza emotiva. Non si tratta di “capricci” o di semplici diete sbagliate, ma di vere e proprie malattie che compromettono la salute fisica, psicologica e sociale dell’individuo.
Le forme più comuni sono:
- Anoressia nervosa: restrizione estrema dell’assunzione di cibo, paura intensa di ingrassare, distorsione dell’immagine corporea.
- Bulimia nervosa: abbuffate seguite da comportamenti compensatori (vomito autoindotto, uso di lassativi, digiuno).
- Disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating disorder): abbuffate ricorrenti senza compensazione, spesso accompagnate da senso di colpa e vergogna.
- Disturbi non altrimenti specificati (NAS): forme miste o atipiche che non rientrano nelle categorie classiche.
I numeri in Italia: una crescita silenziosa
Secondo i dati del Ministero della Salute, oltre 3,6 milioni di persone in Italia soffrono di disturbi alimentari. Il 76,8% dei casi riguarda adolescenti e giovani adulti, con un’età media di esordio tra i 15 e i 19 anni. In alcune regioni, come la Lombardia, si è registrato un aumento del 30% dei casi tra il 2019 e il 20233.
La pandemia ha aggravato il quadro: isolamento, stress, iperconnessione e mancanza di supporto hanno fatto esplodere le richieste di aiuto. Eppure, molti continuano a non ricevere una diagnosi tempestiva, né un trattamento adeguato.
Calabria: tra invisibilità e resistenza
In Calabria, il disturbo alimentare è ancora poco riconosciuto. Mancano centri specializzati, campagne di sensibilizzazione e percorsi strutturati. Eppure, le storie ci sono. Giovani che si nascondono dietro abiti larghi, genitori che non sanno come intervenire, insegnanti che colgono segnali ma non hanno strumenti. La sofferenza è reale, ma spesso invisibile.
Proprio per questo, è fondamentale che le istituzioni regionali investano in formazione, prevenzione e assistenza. La creazione di una rete territoriale dedicata ai disturbi alimentari potrebbe salvare vite e restituire dignità a chi lotta ogni giorno.
Nella la tana del coniglio: il viaggio di chi combatte
Il libro Nella tana del coniglio di Francesca Fialdini offre una chiave di lettura potente e poetica. Attraverso testimonianze, riflessioni e dialoghi con esperti, l’autrice ci conduce nel mondo interiore di chi vive un disturbo alimentare. La “tana” diventa metafora di un rifugio doloroso, dove il controllo sul cibo è l’unico modo per sopravvivere al caos emotivo.
Le voci raccolte nel libro parlano di fame e di vuoto, di regole inflessibili e di rituali quotidiani, di paura e di desiderio di guarigione. Non c’è spettacolarizzazione, ma rispetto. Non c’è giudizio, ma ascolto. E questo è il primo passo per costruire una narrazione diversa: più umana, più vera.
Le radici del disturbo alimentare
I disturbi alimentari non hanno una causa unica. Sono il risultato di un intreccio complesso di fattori biologici, psicologici, familiari e sociali. Tra i principali:
- Fattori individuali: bassa autostima, perfezionismo, ansia, depressione.
- Fattori familiari: dinamiche disfunzionali, traumi, ipercontrollo o trascuratezza.
- Fattori socioculturali: pressione estetica, idealizzazione della magrezza, body shaming.
- Eventi scatenanti: lutti, separazioni, cambiamenti scolastici o lavorativi.
Il disturbo alimentare diventa spesso un modo per gestire emozioni ingestibili, per sentirsi “forti” o “in controllo” in un mondo che sembra troppo caotico.
Sintomi e segnali da non ignorare
Riconoscere un disturbo alimentare può rivelarsi estremamente complesso, soprattutto perché chi ne è colpito tende, il più delle volte, a nascondere i sintomi per paura, vergogna o senso di colpa. Di conseguenza, il disagio resta spesso invisibile agli occhi di familiari, insegnanti e amici.
Nonostante ciò, esistono alcuni segnali che, se osservati con attenzione, possono contribuire a individuare precocemente il problema. Tra i più comuni, si possono citare la perdita o l’aumento di peso improvviso, l’ossessione per le calorie e l’attività fisica, il rifiuto di mangiare in pubblico, nonché la comparsa di rituali rigidi legati al cibo. Inoltre, cambiamenti dell’umore, isolamento sociale e sintomi fisici come pelle secca, capelli fragili o disturbi gastrointestinali rappresentano ulteriori campanelli d’allarme da non sottovalutare.
- Perdita o aumento di peso improvviso.
- Ossessione per calorie, diete, esercizio fisico.
- Rifiuto di mangiare in pubblico.
- Comportamenti rituali legati al cibo.
- Cambiamenti dell’umore, isolamento, irritabilità.
- Segni fisici: pelle secca, capelli fragili, amenorrea, problemi gastrointestinali.
Se si sospetta un disturbo alimentare, è fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati e non improvvisare soluzioni.
Percorsi di cura: multidisciplinarietà e ascolto
La cura di un disturbo alimentare richiede un approccio integrato, che coinvolga:
- Medici e nutrizionisti: per monitorare lo stato fisico e impostare un piano alimentare.
- Psicologi e psichiatri: per affrontare le cause profonde e lavorare sulla relazione con il corpo.
- Educatori e familiari: per creare un ambiente di supporto e comprensione.
- Centri specializzati: che offrano percorsi personalizzati, residenziali o ambulatoriali.
La guarigione non è lineare, ma possibile. Richiede tempo, pazienza, fiducia. E soprattutto, la certezza che si può uscire dalla tana.
Prevenzione: educare alla consapevolezza
Prevenire i disturbi alimentari significa agire su più livelli:
- Scuole: programmi di educazione alimentare e affettiva, formazione per docenti.
- Media: promozione di modelli corporei realistici e inclusivi.
- Famiglie: dialogo aperto, attenzione ai segnali, sostegno emotivo.
- Istituzioni: campagne di sensibilizzazione, fondi per la salute mentale, mappatura dei servizi.
Ogni gesto conta. Ogni parola può fare la differenza. E ogni storia può diventare seme di cambiamento.
Dare voce a chi non riesce a parlare
Il disturbo alimentare è una ferita che spesso non si vede, ma che lacera profondamente. In questa Giornata Mondiale dell’Alimentazione, scegliere di parlarne è un atto di responsabilità e di amore. Per chi sta lottando. Per chi ha paura. Per chi non sa come chiedere aiuto.
Che il libro Nella tana del coniglio ci insegni a guardare oltre il sintomo, a riconoscere la persona, a costruire ponti. E che ogni parola scritta oggi possa diventare carezza, possibilità, futuro.