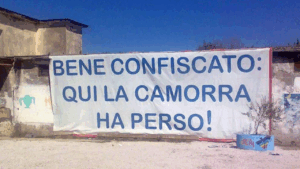Quando l’intelligenza artificiale entra nei processi e nel mondo della giustizia, alla toga non spetta solo combattere per difendere il diritto, ma anche la sua umanità. La nostra era è da tempo caratterizzata da un processo di digitalizzazione importante, che interessa tutti i campi, tutte le materie, tutte le classi sociali. Non poteva sfuggire a questo inesorabile processo di evoluzione anche il mondo complesso ed affascinante del diritto. Nella aule di giustizia l’intelligenza artificiale sempre più non si limita ad essere un semplice concetto futuristico, ma, difatti, assume una posizione sempre più centrale che va, pertanto, disciplinata, limitata, educata.
I nuovi software a servizio della giustizia
Software che analizzano migliaia di intercettazioni, sistemi che collegano conti bancari e conversazioni, algoritmi che segnalano “comportamenti sospetti”. No, non è una fiction televisiva ma è sempre più realtà. É la nuova giustizia, che possiamo definire digitale, una giustizia che certamente potrebbe risultare agli occhi delle persone comuni più efficiente e veloce, ma che in realtà rende tutto pericolosamente impersonale, disanimato. In un mondo come quello delle aule di giustizia, molto legato alla procedura ed a consolidati formalismi, l’avvento dell’intelligenza artificiali non poteva che sconvolgere i consolidati ed antichi equilibri dei Tribunali.
In questa nuova giustizia la figura del penalista cambia pelle
Oggi l’avvocato penalista, anche all’interno della stessa categoria, praticamente, non difende più l’imputato, ma è costretto ad ergersi a baluardo ultimo del principio su cui si basa lo stesso concetto di giustizia, ossia il sacrosanto diritto di ogni persona ad essere giudicata da uomini, giammai da fredde macchine, ancore imperfette ed in ogni caso incapaci di adeguare al caso concreto l’applicazione del diritto, penale in particolare.
La testimonianza di un penalista che frequenta le aule di giustizia…
Oggi bisognerebbe quindi prima comprendere come ragiona un algoritmo o come potrebbe ragionare un giudice ? Tuttavia la verità è che la missione di un operatore del diritto, prima ancora che professione, non può ridursi all’analisi tout court di dati freddi, ma, difatti, si rende sempre di più necessario ascoltare, imparare ad aprirsi agli altri, capacità di comprendere le vite altrui, trovare in ogni modo il senso umano dietro ogni fatto. L’AI non potrà mai sostituire questo.
L’algoritmo: esempio di ingerenza nella nuova era della giustizia digitale
In molti fascicoli d’indagine potrebbero essere sempre più presenti report generati da algoritmi di intelligenza artificiale: intercettazioni filtrate automaticamente, trascrizioni “intelligenti”, analisi predittive dei movimenti bancari. Strumenti utili, certo, ma che sollevano interrogativi cruciali. Quando si consente, ad esempio, ad un software di decidere quali conversazioni siano “rilevanti”, in che modo la difesa potrà comprendere come lo stesso avrà ragionato? Si rischierebbe così di non poter più contestare più un fatto, ma un risultato matematico impossibile da verificare. Oggi, inoltre, si assiste alla necessità di regolamentare anche le stesure degli stessi atti difensivi, spesso generati in maniera tutt’altra che corretta da piattaforme di intelligenza artificiale non verificate né, tantomeno, riscontrate.
Il valore dello studio e della ricerca
Per affrontare questa nuova era, il penalista deve riscoprire la profondità dello studio e la curiosità della ricerca. Serve competenza tecnica, ma anche cultura giuridica e sensibilità umana. Saper leggere un log informatico conta quanto saper leggere un volto, un silenzio, un gesto. Ogni processo è prima di tutto una storia da comprendere, analizzare, interpretare. L’intelligenza artificiale può vedere i dati, ma non capisce e non capirà mai le persone. Il compito quindi del penalista è sempre più riportare il diritto al suo nucleo umano: la comprensione della fragilità, del dubbio, della responsabilità.
Tecnologia e giustizia: un equilibrio da trovare
Nel 2026 entrerà in vigore la nuova direttiva europea che obbligherà le autorità a rendere trasparenti gli algoritmi usati nelle indagini penali. Un passo avanti importante, ma non sufficiente. Perché la giustizia non è solo una somma di informazioni: è un percorso di ricerca della verità, fatto anche di errori, intuizioni, empatia. Certo, ancora oggi, per fortuna, viviamo una giustizia fatta da persone, uomini e donne, che hanno a cuore il loro lavoro, si sacrificano ed impiegano passione, ma per una volta, sarebbe il caso di studiare alternative e regolamentazioni tali da rendere in anticipo l’AI uno strumento di ausilio, e non un surrogato pericoloso capace di standardizzare un mondo che da sempre ha inteso la sua missione nella capacità di comprendere il singolo individuo a tutela della collettività.
Il penalista del futuro
In un’epoca dominata dai big data, il penalista resta l’ultimo interprete umano del dubbio. Sa che dietro ogni codice informatico c’è un codice morale, e che la verità non si calcola: si costruisce, con studio, fatica e ascolto. La tecnologia può aiutarci a vedere di più ma solo lo studio e l’umanità ci rendono persone capaci di capire l’altro, di aiutare l’altro, di poterlo difendere in maniera equa e giusta. Difendere un imputato significa ancora, e sempre, difendere l’uomo