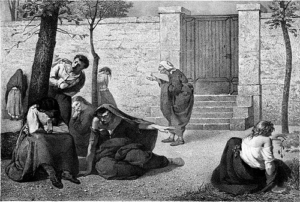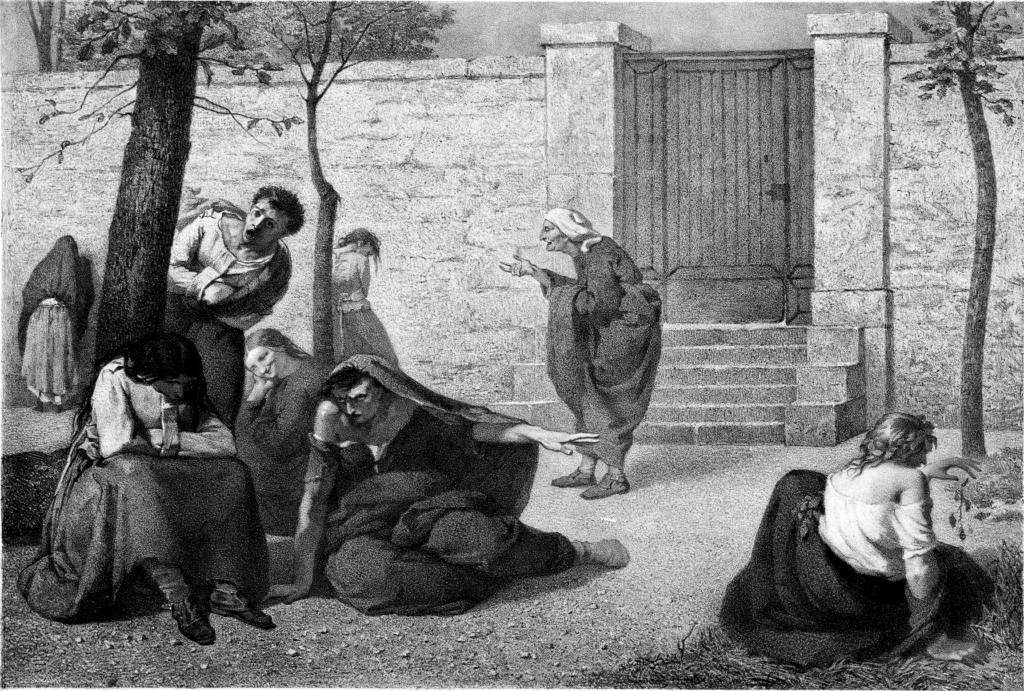
Fonte foto: Wikipedia
Salute mentale raccontata attraverso parole che accolgono e trasformano
La salute mentale è un territorio fragile e profondo, spesso trascurato, talvolta temuto. Eppure, è lì che si annidano le domande più urgenti: chi siamo, cosa ci ferisce, come possiamo guarire. Ho voluto approfondire questo tema con la scrittrice Grazia De Gennaro, la cui sensibilità narrativa si intreccia con una riflessione lucida e necessaria sul benessere emotivo.
La scrittura come atto di ascolto e resistenza
Nel corso dell’intervista, Grazia ha condiviso pensieri che non sono solo parole, ma gesti di cura. La scrittura, per lei, è uno strumento di ascolto, una forma di resistenza, un modo per dare voce a ciò che spesso resta invisibile. Abbiamo parlato di fragilità, di stigma, di come la società fatichi ancora a riconoscere il dolore psichico come parte integrante dell’esperienza umana.Questo dialogo è un invito a rallentare, a leggere tra le righe, a costruire spazi di empatia. Perché la salute mentale non è un tema da specialisti, ma una responsabilità collettiva. E la letteratura, quando incontra il vissuto, può diventare ponte, rifugio, possibilità.
Grazie, Grazia, per aver accettato questa intervista nonostante i tuoi numerosi impegni. È un onore poterti ascoltare su un tema così urgente e delicato. Partiamo da qui: cosa significa per te “salute mentale” oggi, in una società che ancora fatica a nominarla senza imbarazzo?
“Per me, la salute mentale è determinata da un equilibrio fra ciò che siamo, emozioni, pensieri il nostro vissuto, e il mondo esterno. Dunque, dobbiamo inevitabilmente imparare a sintonizzarci con gli altri, ma senza mai perdere di vista il nostro valore, il potenziale, i sani confini. Secondo la definizione dell’ONU, la salute non è semplicemente assenza di malattia, ma uno stato di benessere psicofisico globale. Se tali elementi di mutua regolazione si disarticolano, l’equilibrio si rompe. Io ho vissuto sulla mia pelle la depressione ansiosa: mi sentivo sprofondare, come se fossi in un pozzo. Non vedevo più la luce della mia vita, solo il buio del mio dolore”.
Nel tuo lavoro di scrittrice, come racconteresti il disagio mentale in un tuo romanzo?
“La scrittura è la maniera più naturale per esternare quello che abbiamo dentro, ed è stato ciò che mi ha salvata. Da scrittrice, se dovessi raccontare questo spaccato, farei attenzione ad alcuni dettagli: primo, rischiare di incorrere in cliché che non tengono mai conto di quello che prova davvero chi ne è affetto, ma parlare solo per sentito dire. Secondo, la disinformazione, che è la causa delle narrazioni sbagliate sulla salute e la malattia mentale. Terzo, la mancanza di sensibilità e tatto, entrate ormai nel linguaggio corrente con parole come pazzo/a, psicopatico/a, narcisista ecc. Un abuso estremamente pericoloso, perché porta a una patologizzazione di aspetti che, in realtà, non hanno nulla di anomalo. Oltre che essere termini di per sé offensivi nei confronti di chi sta male”.
Quanto incide il contesto territoriale—penso al Sud Italia, alle periferie, ai piccoli comuni—nella percezione e nell’accesso alla cura psicologica?
“Purtroppo, essere nati nella parte giusta del mondo, del paese o addirittura della città, incide moltissimo non solo sulla percezione del bisogno di aiuto, ma anche in termini di cure e servizi. In particolare al Sud, la cultura della salute mentale non esiste, tant’è vero che il ceto medio della popolazione meridionale non può permettersi uno psicologo privato, e spesso neanche di intraprendere un primo accesso per l’iter alla ASL. Poiché la malattia mentale, il più delle volte, non presenta sintomi fisici, allora viene sottovalutata. Non ha la stessa dignità di un tumore o una leucemia, è un diritto che sempre più spesso viene calpestato”.
Hai incontrato storie che ti hanno fatto riflettere sul confine tra fragilità e resistenza? Quanto la resilienza può essere fraintesa come negazione del dolore?
“La negazione del dolore, la cosiddetta “positività tossica”, è uno dei requisiti da aborrire. Stare bene, nel senso più comune del termine, significa essere sempre felici. Il concetto stesso di resilienza viene strumentalizzato: è considerata non la capacità di tornare a star bene dopo aver affrontato le difficoltà, ma quella di non crollare mai. Non c’è concetto più velenoso: bisogna sfracellarsi, se necessario, per poi ricostruirsi più forti. Tra le mie esperienze, ho visto un nonno spegnersi lentamente per la demenza senile, ed è allora che ho iniziato a fare i conti per la prima volta con una condizione che altera il Sé. Ho dovuto combattere per accettare la sua spersonalizzazione, e lo sgomento che ne conseguiva”.
Come giornalista, quali responsabilità abbiamo nel raccontare la salute mentale senza cadere nel pietismo o nella spettacolarizzazione?
“Nelle nostre vesti di giornaliste, sicuramente dobbiamo cercare di fornire informazioni il più possibile complete e veritiere, ma credo che il modo migliore per non spettacolarizzare la malattia mentale sia prestare uno spazio e una voce a chi si trova in condizioni di sofferenza. Bisogna un po’ scomparire, ovvero limitarsi a riportare fatti e testimonianze, senza giudizi non richiesti o cercare di conquistare il centro della scena. Soprattutto, tenendo presente che il malato ha una dignità, per cui non bisogna mostrarlo in condizioni di sofferenza o descrivere contesti e attività che potrebbero essere umilianti per lui. Oltre a essere deontologicamente sbagliato, denota una grande mancanza di umanità”.
Secondo te, quali sono le parole che mancano nel vocabolario istituzionale quando si parla di salute mentale?
“Io credo che, per quanto riguarda la salute mentale, la parola più importante che manchi un po’ dovunque, non solo nelle istituzioni, sia empatia. La verità, è che non si riesce a comprendere davvero la sofferenza di qualcun altro se non è passata sulla propria pelle. Per questo motivo, non si pensano a soluzioni di problemi anche gravi, come la mancanza di strutture che eroghino servizi, il supporto psicologico per i caregiver, che spesso sono familiari e quindi hanno un legame emotivo con il malato, l’assenza di incentivi –soprattutto economici- per pagare le terapie. La società si disinteressa ai bisogni di un malato in generale, ma soprattutto mentale, e dei suoi cari, per il semplice fatto che una persona così inabile non è produttiva. Per questo, i costi di spese mediche e personali, se non coperte dal SSN, sono a carico della famiglia, il primo (e in questi casi unico) ammortizzatore sociale”.
La salute mentale è spesso intrecciata con la condizione femminile, la maternità, la violenza. Come possiamo affrontare queste intersezioni con maggiore consapevolezza?
“Le donne, a causa delle aspettative sociali ma anche stereotipi di genere, sono soggetti molto a rischio. Senza contare che, per il fatto che siano considerate risorse sacrificabili nella famiglia per quanto riguarda il lavoro, sono spesso costrette alla dipendenza economica. Tutte queste pressioni, possono sviluppare disturbi psichici. Il problema delle donne è che vengono considerate utili, non indispensabili, ovvero non in quanto individui che possano contribuire alla società, ma per la loro funzione biologica. Vanno rafforzati il sussidio alla maternità, interventi dei CAV per garantire l’autonomia delle donne vittime di violenza, supporti alla genitorialità, soprattutto a livello territoriale, ma sicuramente il primo intervento, il più importante, è quello di cambiare la mentalità degli uomini, ma anche delle donne stesse. Troppo abituate alla rinuncia e alla dipendenza, spesso non chiedono aiuto in situazioni d’emergenza”.
Nel tuo attivismo, quanto spazio ha la salute mentale? È riconosciuta come parte integrante dei diritti civili?
“Naturalmente, sì. Da quando ho avuto la depressione, il mio livello di guardia sul tema è notevolmente aumentato. Ho scelto di raccontare il mio percorso farmacologico, che ora ho interrotto, e di psicoterapia, ancora in corso, su una rubrica del mio blog. Il mio scopo era altruistico, cioè sensibilizzare l’opinione pubblica, che spesso sottovaluta e mistifica l’importanza della salute mentale, rimuovere lo stigma, e anche egoistico. Era necessario che la mia autostima si accrescesse e sapessi di essere anch’io importante. Era importante per me essere vista, sentita, sostenuta”.
Come ti relazioni personalmente al tema della salute mentale? Hai rituali, pratiche, spazi che proteggono il tuo equilibrio interiore?
“Il problema principale è la gestione dell’ansia. Una cosa affatto semplice, dal momento che i normali livelli fisiologici si trasformano, per me, in una sofferenza, che condizionava la mia vita quotidiana. Lo psicologo mi ha assegnato degli esercizi appositi per gestirla, soprattutto quando la mia tendenza al controllo sfocia in compulsioni, ovvero comportamenti ripetitivi e ossessivi. Una graduale esposizione alle situazioni di panico ha contribuito a rafforzare la mia autonomia. Ho dovuto fare un grande lavoro di analisi delle mie emozioni, imparare ad ascoltare i miei pensieri senza esserne distrutta”.
Se potessi lanciare una campagna nazionale, quale sarebbe il suo messaggio centrale? A chi vorresti parlare davvero? Ti ringrazio di cuore per questo dialogo generoso e profondo: le tue parole sono un invito alla cura, alla consapevolezza e alla responsabilità collettiva.
“Se dovessi organizzare una campagna, non mi rivolgerei direttamente agli ammalati, ma non perché non siano importanti, ma a coloro che non intendono raccontare i fatti propri a uno psicologo, diffidano dai farmaci perché sono spaventati dall’effetto sulla psiche, e soprattutto a quelli che pensano che chi chiede aiuto sia un debole, o addirittura pazzo. Chi sta male ha bisogno anche del supporto delle persone che stanno loro intorno. Sentirsi amati è già un ottimo inizio per poter guarire”.